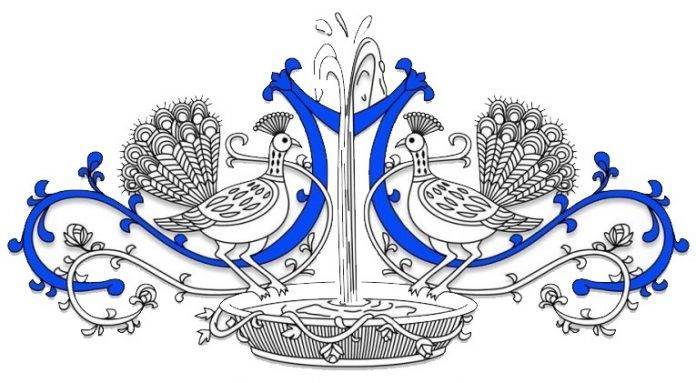
La chiusura della redazione romana del Giornale, annunciata dal gruppo che fa capo al quotidiano fondato da Indro Montanelli, porta con sé almeno due considerazioni. La prima è quella relativa al progressivo disinteresse, nelle strategie di sviluppo, delle aziende editoriali nei confronti di Roma.
Sia pur in una fase di appannamento (molto mediatico), la Città Eterna resta la Capitale del Paese e, quindi, sede naturale di politica e pubblica amministrazione. Proprio questa sua caratteristica ha portato, negli anni, le principali testate nazionali a pensare a una presenza stabile nell'Urbe, anche quando la sede principale si trovasse altrove. E' chiaro che le nuove tecnologie – azzerando le distanze e accrescendo il ruolo giocato dal singolo cittadino nel processo informativo (quello che gli anglosassoni chiamano citizen journalism) – abbiano significativamente ridotto tale esigenza. Ma questo, da solo, non può bastare per giustificare un fuggi-fuggi che, a memoria, non ha precedenti in altri Paesi.
Prima Sky (tra Sport 24 e Tg24, che hanno lasciato a Roma solo una modesta rappresentanza), poi Libero e ora Il Giornale, senza dimenticare il progetto di espansione del Tg2 a Milano. Il tutto è avvenuto con modalità che hanno lasciato a dipendenti e cronisti due sole opzioni: fare armi e bagagli in direzione nord o cercarsi un nuovo lavoro. Oggi, al netto delle sede di piazza Venezia del Corriere della Sera, e della Rai (che è comunque un ibrido fra organismo d'informazione e pubblica amministrazione), a Roma, delle principali testate nazionali, resta la sola Repubblica. Tutto il resto (eccetto la Stampa) è a Milano, che non è capitale politica ma della finanza, a testimoniare (nei tempi che viviamo) la prevalenza della seconda sulla prima.
La seconda considerazione riguarda la crisi del settore, che porta i gruppi editoriali a entrare nell'ottica dell'austerity, con accorpamenti e pesanti tagli. Il risultato sono redazioni sempre più ristrette e poco presenti nei territori, nelle quali il grosso del lavoro è quello di desk, cioè alla scrivania. Il risultato? Un calo qualitativo e la preponderanza del commento sulla notizia in sé. La nuova velocità imposta dal web 2.0 (cioè da motori di ricerca e social media) obbliga poi a una concorrenza spietata, nel quale l'articolo intellettualmente onesto scritto seguendo l'aurea regola dell'acquisizione e verifica del fatto diventa merce sacrificabile sull'altare del clic, o del lettore in più. La perdita di credibilità porta il calo di vendite, che, a sua volta, determina nuove scelte editoriali spregiudicate.
L'ultimo passaggio, per chi si è guadagnato il diritto di sopravvivere, è quello delle operazioni di salvataggio, che non sono mai gratis. Non solo in termini economici, ma di libertà di stampa. Perché se una banca o un manager privato siede nel consiglio d'amministrazione di un gruppo editoriale, quali margini di manovra avrà il direttore di un giornale o un cronista nel raccontare, magari, fatti scomodi che riguardano proprio chi lo paga?
Sino a oggi la crisi è stata gestita, per lo più, con misure tampone, o facendo proclami su scenari poco praticabili, come quello degli “editori puri” evocato qualche mese fa dal ministro Di Maio. La verità è che nessuno sa con esattezza, non tanto quando, ma “se” il settore vedrà mai la luce alla fine del tunnel. Un tentativo, in ogni caso, va fatto, avviando una riforma del comparto stampa, che parta da una valutazione globale della situazione, analizzi con la giusta dose di cinismo cosa va tenuto e quanto va sacrificato e prenda atto, in modo serio, dell'evoluzione tecnologica, che non è solo un quid in più dell'informazione, ma la dimensione, il cosmo, all'interno del quale dovrà muoversi d'ora in avanti. Serve una “visione”, un nuovo orizzonte, verso il quale condurre la nave in tempesta. Prima che sia troppo tardi, anche solo per provarci.









